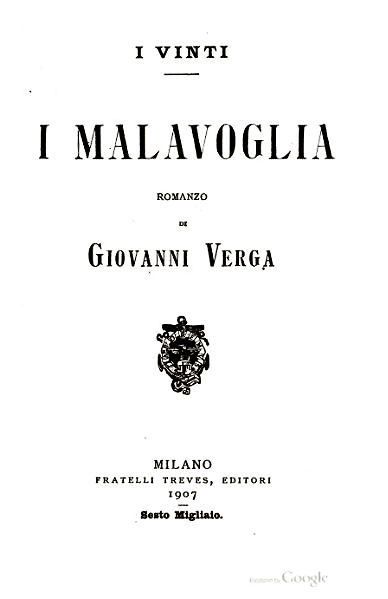
I Malavoglia – Frontespizio di un’edizione del 1907 – Wikipedia, pubblico dominio.
È un tempo circolare, che si ripete eternamente uguale a se stesso, e in cui la saggezza popolare si condensa nei proverbi, autentici depositari di verità antiche e universali. Questo tempo si radica nei riferimenti naturali del mare, del cielo, delle costellazioni: elementi immutabili, che accompagnano da sempre la vita della comunità.
Il romanzo si apre e si chiude con lo stesso scenario, quello del paese osservato da ‘Ntoni nel finale.
Da un lato, questo ritorno conclude in modo ciclico la vicenda, con Alessi che prende il posto del nonno; dall’altro, segnala una frattura: ‘Ntoni parte per un viaggio senza ritorno, simbolo dell’irruzione del tempo della storia nella vita arcaica del villaggio (si veda l’episodio emblematico de L’addio di ‘Ntoni).
Infatti, il tempo storico non è assente dal romanzo, ma si manifesta fin dalle prime pagine. Gli eventi che travolgono la famiglia Malavoglia si collocano tra il 1865 e il 1878, anni in cui la storia nazionale – la leva obbligatoria, le tasse, la battaglia di Lissa – irrompe nel microcosmo della vita rurale.
Anche i segni del progresso, come la pesca industriale o il treno che porta via i coscritti, destabilizzano l’equilibrio ciclico della comunità di Aci Trezza.
Il primo vero segno di crisi arriva con la partenza di ‘Ntoni per il servizio militare, che avvia una catena di eventi drammatici: il commercio fallimentare dei lupini, il naufragio della Provvidenza, la morte di Luca in guerra. L’incontro di ‘Ntoni con il mondo moderno, durante il suo soggiorno “nel Continente“, mette in discussione l’intero sistema di valori del nonno padron ‘Ntoni, fondato sull’onore, sul lavoro e sulla famiglia.
L’irruzione della storia provoca così il disgregarsi della società patriarcale: tra il mondo antico e quello moderno non esiste comunicazione, né possibilità di conciliazione.
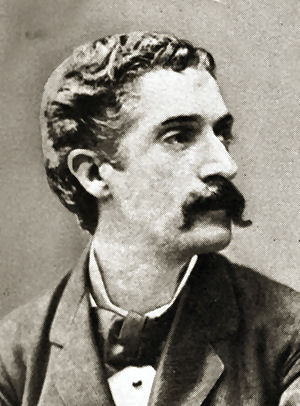
Ritratto di Giovanni Verga, autore de “I Malavoglia” – Wikipedia, pubblico dominio.
Questa opposizione tra tempo della natura e tempo del progresso si riflette anche nel ritmo narrativo del romanzo.
Nei quindici capitoli, si assiste a un progressivo dilatarsi del tempo storico e a una crescente concentrazione del tempo del racconto.
Nella prima parte domina padron ‘Ntoni, figura che incarna la stabilità della legge patriarcale.
Nella seconda parte, invece, il protagonista diventa il giovane ‘Ntoni, portatore della tensione moderna verso il progresso e la ricchezza.
Anche i tempi verbali sottolineano il contrasto: l’imperfetto – tempo della ripetizione, della coralità, della vita che scorre uguale – lascia progressivamente spazio al passato remoto, tempo della frattura, della svolta, del cambiamento. Il passato remoto accompagna il dramma individuale di ‘Ntoni e introduce nella narrazione il tempo della storia, segnando il distacco dalle antiche radici e il tramonto di un’intera civiltà.
A questa contrapposizione temporale corrisponde un’altrettanto netta contrapposizione spaziale: quella tra il paese e la città.

Giovanni Crupi (1849-1925), “Scogli dei Ciclopi – Aci Trezza” – Wikipedia, pubblico dominio.
L’universo di Aci Trezza è chiuso, statico, quasi autosufficiente. Il romanzo, scritto dal punto di vista del narratore popolare, restituisce uno spazio astorico, idealizzato, dove la vita collettiva si svolge in luoghi simbolici, la piazza, l’osteria, il lavatoio, le botteghe, ma mai con una rappresentazione realistica e concreta. Le case, comprese quella del nespolo, sono descritte solo dall’esterno. A uno spazio etnologico corrisponde così un tempo mitico, sospeso, che riflette la nostalgia per un mondo semplice e ordinato, contrapposto alle passioni e al caos del mondo moderno.
Fuori da Aci Trezza c’è l’ignoto: Riposto, Catania, Napoli, Trieste sono luoghi lontani e minacciosi, simboli di smarrimento e perdizione. Ma lo spazio esterno è anche fonte di attrazione. Per ‘Ntoni, la città rappresenta il benessere, il lusso, la libertà, in contrasto con la vita faticosa del paese. È lo spazio della fuga e del sogno, ma anche della disillusione.
L’esperienza del mondo esterno innesca in ‘Ntoni una profonda crisi: la morale del sacrificio e del dovere viene sostituita dalla ricerca di una vita diversa, e così si rompe il legame con la tradizione e con la famiglia.
Tuttavia, anche lo spazio del paese non è privo di ambiguità. Esso appare rifugio protettivo per figure come padron ‘Ntoni, Mena o compare Alfio, ed è mitizzato nei ricordi di ‘Ntoni.
Ma non è un luogo idilliaco: è attraversato da conflitti, avidità, meschinità. Personaggi come zio Crocifisso, compare Piedipapera e don Silvestro incarnano la speculazione e l’ipocrisia, e contribuiscono alla rovina dei Malavoglia.

Museo Casa del Nespolo – Museo di Aci trezza ispirato alla casa della famiglia Toscano descritta nel libro “I Malavoglia” di Giovanni Verga. – Wikipedia – Foto di Giovanni.grasso rilasciata cob licenza CC BY-SA 4.0
All’interno del paese, l’unico spazio veramente positivo è la casa del nespolo: luogo familiare, affettivo, punto fermo contro la violenza del mondo esterno. Persino ‘Ntoni, pur ribellandosi, ne avverte la forza. Per amore della madre sceglie di restare, sacrificando anche i propri sentimenti per Barbara. Ma la corrente della storia è inarrestabile: il tempo del progresso avanza, travolgendo i vecchi equilibri. La famiglia, pur coesa, cede sotto i colpi del cambiamento. La partenza di ‘Ntoni e la fuga di Lia segnano la rottura definitiva.
È questo il punto di non ritorno: la coscienza verghiana registra la crisi storica della famiglia e con essa la fine del romanzo idillico e patriarcale. L’ingresso nel tempo moderno è doloroso, lacerante, ma inevitabile.
.




