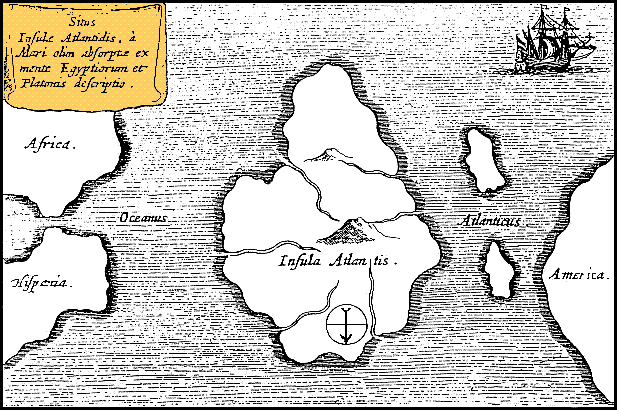Il legame tra Napoli e l’esoterismo si fa particolarmente affascinante durante il Medioevo, in epoca normanna e angioina, quando si diffuse con grande forza la leggenda di Virgilio il Mago.

John Dryden – Le opere di Virgilio (1697), frontespizio – Wikipedia, pubblico dominio
La relazione tra il poeta latino e la città di Neapolis è profonda e articolata.
Napoli, che ancora oggi ne custodisce la tomba nel parco di Fuorigrotta che porta il suo nome, ha sempre espresso per Virgilio un duplice sentimento: da un lato l’ammirazione colta per la sua opera poetica, dall’altro la devozione popolare per l’uomo che fu considerato un mago e un protettore della città, capace – secondo la leggenda – di scacciare sciagure, insetti e serpenti grazie a misteriosi incantesimi.
Tra le tracce più suggestive di questa tradizione si trova l’origine del nome “Castel dell’Ovo”, attribuito alla fortezza costruita sull’isolotto di Megaride (anticamente chiamato S. Salvatore), oggi collegato artificialmente alla terraferma dal Borgo Marinaro.
A prima vista, l’etimologia del nome potrebbe sembrare bizzarra, ma assume tutt’altra luce se letta attraverso il simbolismo dell’alchimia. Nell’ambito ermetico, l’“uovo filosofico” è il nome dato all’athanor, il forno chiuso – di metallo o vetro speciale – nel quale avveniva la lenta trasmutazione degli elementi primari, zolfo e mercurio, in oro. Un processo non solo materiale, ma spirituale: una trasformazione dell’anima e dell’intelletto dell’operatore.
Durante il Medioevo, Napoli divenne un importante centro di studi ermetici e alchemici. I procedimenti di calcinazione, liquefazione e soluzione trovavano terreno fertile nella particolare composizione vulcanica offerta dal Vesuvio. L’acqua marina distillata era considerata l’unico valido sostituto della rugiada alchemica, raccolta di notte e ritenuta pura manifestazione del cosmo.
L’isolotto di Megaride, già in epoca classica, ospitò eremiti e sapienti che trovarono rifugio tra le grotte e i resti della fastosa villa di Lucullo, un tempo estesa fino alle pendici del Pizzofalcone. Più tardi, i monaci basiliani riutilizzarono le colonne romane per costruire il cenobio, i cui resti si possono ancora ammirare all’interno del castello. Proprio nei monasteri medievali, spesso, venivano celate pratiche alchemiche e spirituali, ed è documentata la presenza di monaci alchimisti sull’isolotto.
Un antico manoscritto narra la storia di un amanuense che avrebbe dedicato l’intera vita alla trascrizione e allo studio delle opere di Virgilio. Questo aneddoto, insieme a numerose testimonianze storiche, conferma quanto la cultura virgiliana fosse profondamente radicata tra i dotti e il clero napoletano tra il periodo angioino e il Rinascimento aragonese. L’amore della città per il poeta mantovano è, dunque, tanto culturale quanto spirituale.
Secondo una delle leggende più famose, Virgilio avrebbe nascosto un uovo magico all’interno del castello, chiuso in una gabbietta e murato in una nicchia delle fondamenta. Disse che, se l’uovo si fosse rotto, l’intera città sarebbe crollata con esso. In un’altra versione, l’uovo era contenuto in una caraffa di cristallo, sigillata e nascosta sempre all’interno della fortezza. Da queste storie prende forma il nome stesso del Castel dell’Ovo, confermato da numerose fonti scritte e da una persistente tradizione orale.

Napoli, Castel dell’Ovo – Vecchia stampa – Wikipedia, pubblico dominio
Secondo alcune ipotesi, Virgilio avrebbe appreso l’arte della distillazione da un adepto dei misteri orfici ancora attivo nelle campagne napoletane. Avrebbe poi svolto i suoi esperimenti nei laboratori segreti di eleganti ville patrizie, protetto da illustri mecenati che – su consiglio dello stesso Ottaviano – garantirono al poeta un soggiorno tranquillo e operoso a Napoli.
Virgilio aveva studiato proprio in città, alla scuola del filosofo epicureo Sirone, e nutriva profonda ammirazione per autori come Esiodo e Lucrezio. Con il tempo, si sarebbe avvicinato ai culti misterici di Cerere e Proserpina, ancora molto vivi nella Neapolis di allora, approfondendo i segreti della natura e dei suoi cicli più occulti.
Ma allora, Virgilio fu davvero un mago? Un precursore degli alchimisti?
Forse sì, se si considera che anche Dante Alighieri, il più “iniziato” dei poeti italiani, autore della Divina Commedia – che molti leggono anche in chiave esoterica – scelse proprio Virgilio come sua guida spirituale. Dante stesso era affiliato ai Fedeli d’Amore, e iscritto alla corporazione dei medici e speziali di Firenze.
Quel che è certo è che Napoli amò profondamente Virgilio, considerandolo a lungo una sorta di protettore della città, addirittura prima ancora di San Gennaro. E sebbene sia morto a Brindisi nel 19 a.C., la città non ha mai smesso di venerarne la tomba, come un’antica reliquia di poesia e mistero.
vedi anche:
,
..